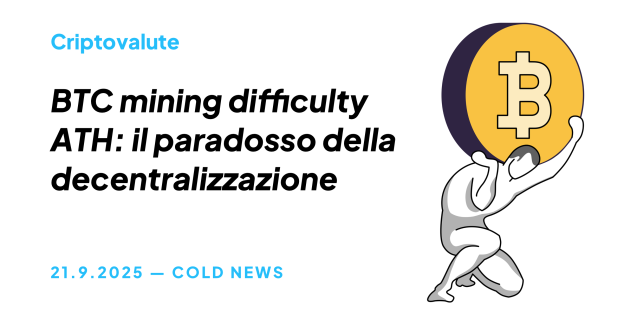La difficoltà del mining di Bitcoin ha raggiunto un nuovo all-time high, superando i 142 trilioni, mentre l’hashrate medio ha varcato stabilmente la soglia di 1,1 ZH/s.
Si tratta di un record che non stupisce se letto alla luce dell’ultimo halving, avvenuto ad aprile 2024, quando la ricompensa per blocco è stata dimezzata a 3,125 BTC. La dinamica è nota: a fronte di una minore remunerazione in termini unitari, il sistema tende a espellere progressivamente gli operatori meno efficienti, mentre coloro che possono contare su infrastrutture industriali e approvvigionamenti energetici a basso costo si rafforzano, incrementando la potenza computazionale e innalzando la difficoltà. In astratto, ciò corrisponde a un meccanismo di autoregolazione: la rete diventa più sicura proprio perché più difficile da attaccare. In concreto, tuttavia, il processo non è neutro, poiché le barriere all’ingresso si alzano fino a restringere il campo ai soli miner dotati di capitali ingenti e capacità di negoziare forniture energetiche su scala globale.
È in questa tensione che si manifesta la fragilità concettuale di Bitcoin: l’idea di un sistema radicalmente distribuito, nato per sottrarsi al controllo centralizzato, si confronta con la logica implacabile dell’economia industriale, dove l’efficienza e la concentrazione di risorse diventano fattori determinanti. La retorica della decentralizzazione entra così in attrito con la realtà di un ecosistema che tende a polarizzarsi intorno a pochi grandi attori, siano essi società quotate in borsa o utility statali che sfruttano la propria capacità produttiva per integrare il mining all’interno di strategie energetiche più ampie. Ne deriva un assetto asimmetrico, in cui il piccolo miner indipendente fatica non soltanto a mantenere la redditività, ma persino a giustificare la propria presenza.
Il timore di centralizzazione non è meramente teorico. Se un numero ristretto di operatori controlla quote rilevanti dell’hashrate globale, si riduce la resilienza della rete a scenari avversi: dall’introduzione di nuove regolazioni restrittive alla possibilità di attacchi opportunistici, dalla pressione politica esercitata sui singoli operatori fino all’impatto di crisi energetiche localizzate. L’architettura distribuita garantisce che il sistema non possa essere catturato facilmente; tuttavia, più l’hashrate si concentra, più la sua distribuzione effettiva dipende dalla volontà o dalle vulnerabilità di un numero limitato di soggetti. Il paradosso è evidente: la sicurezza matematica del protocollo si rafforza proprio nel momento in cui la sicurezza socio-economica della rete si indebolisce.
Eppure, sarebbe riduttivo leggere la crescita della difficoltà unicamente in termini negativi. Esistono almeno tre implicazioni potenzialmente positive che meritano di essere sottolineate. In primo luogo, l’aumento della difficoltà è segnale della solidità economica del sistema: se il mining continua a crescere in termini di investimento e potenza, significa che la fiducia di lungo periodo nella sostenibilità di Bitcoin come asset permane elevata, al punto da giustificare impegni di capitale significativi. Le grandi operazioni industriali, pur restringendo lo spazio ai piccoli operatori, rappresentano al tempo stesso un indicatore che l’ecosistema è in grado di attrarre investimenti su scala globale, alimentando un circuito di professionalizzazione e di accountability che riduce l’improvvisazione tipica delle prime fasi.
In secondo luogo, la centralizzazione relativa nelle mani di operatori regolamentati o visibili sul mercato può, paradossalmente, incrementare la legittimazione istituzionale di Bitcoin. Le società quotate che operano nel mining sono soggette a disclosure, audit e requisiti di trasparenza che contribuiscono a rendere l’ecosistema più leggibile agli occhi dei regolatori e degli investitori istituzionali. Se da un lato questo mina il mito originario del minatore indipendente che alimenta la rete dal proprio garage, dall’altro rafforza la percezione di Bitcoin come infrastruttura economica stabile, capace di integrarsi nei mercati finanziari tradizionali senza scivolare nell’opacità.
Infine, la ricerca di fonti energetiche sempre più efficienti, dettata dalla necessità di ridurre i costi in un contesto di difficoltà crescente, può agire come driver per l’innovazione energetica. Non è un caso che molti grandi miner stiano esplorando soluzioni basate su energie rinnovabili, recupero di gas naturale in eccesso o accordi con produttori di energia a basso impatto ambientale. Se la logica della redditività spinge verso l’ottimizzazione dei consumi, il risultato può coincidere con una maggiore sostenibilità del sistema, capace di allinearsi a obiettivi climatici e di presentarsi come utilizzatore di risorse altrimenti sprecate.
Resta tuttavia irrisolto il nodo strutturale: la difficoltà crescente rappresenta una barriera che ridefinisce continuamente chi può partecipare e a quali condizioni. Gli incentivi economici, spogliati della retorica, conducono a una selezione darwiniana che rafforza gli operatori capaci di industrializzare il processo e marginalizza chi non dispone di tali risorse. È in questo squilibrio che si gioca il futuro di Bitcoin: da un lato, un sistema che diventa sempre più sicuro dal punto di vista tecnico; dall’altro, una rete che rischia di smarrire la sua promessa di accessibilità universale.
Per gli investitori, questo scenario implica una doppia lettura: da una parte, l’aumento della difficoltà può essere interpretato come segnale di robustezza, in grado di alimentare ulteriori ingressi di capitale e di consolidare la narrativa di Bitcoin come “oro digitale” difficilmente attaccabile; dall’altra, l’erosione della decentralizzazione effettiva introduce un elemento di rischio sistemico, meno visibile ma altrettanto rilevante. Per i regolatori, il problema non è soltanto tecnico, ma politico: decidere se lasciare che la dinamica economica produca concentrazione o se intervenire con strumenti che incentivino la dispersione geografica e dimensionale dei miner, magari attraverso politiche fiscali o energetiche.
Il dato di fatto è che la rete, con la sua nuova difficoltà record, si trova in un momento di svolta: più sicura sul piano computazionale, più esposta sul piano socio-economico. In questa contraddizione si riflette l’essenza stessa di Bitcoin, che non smette di oscillare tra la promessa di un ordine spontaneo e la realtà di un’economia che, come tutte, tende alla concentrazione. Il futuro dirà se l’equilibrio tra questi due poli sarà in grado di reggere o se, al contrario, la forza stessa del protocollo diventerà il punto cieco da cui nascerà la sua vulnerabilità.