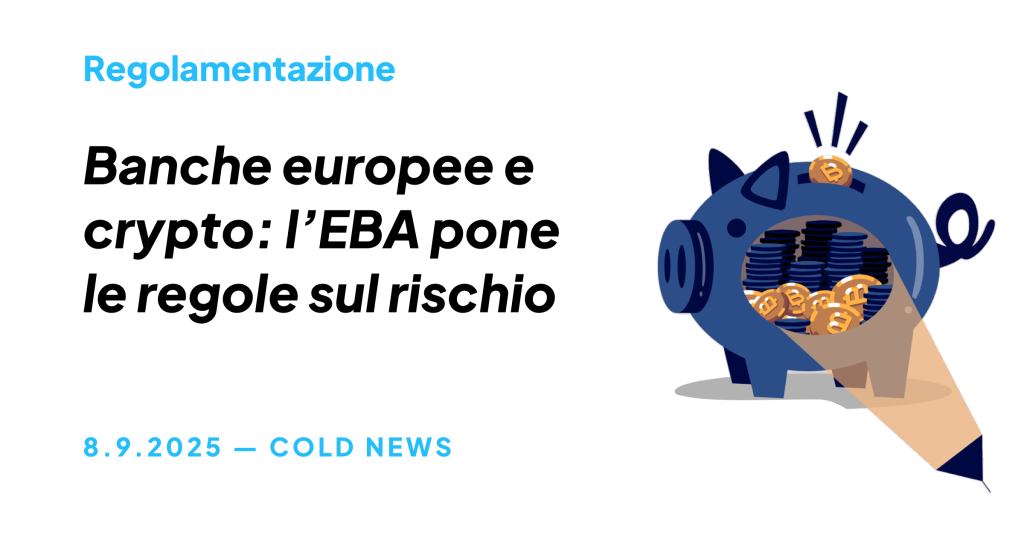La settimana del 15 settembre ha visto emergere una spaccatura significativa tra gli Stati membri dell’Unione Europea sulla governance del regime MiCA. Francia, Italia e Austria hanno presentato una richiesta congiunta affinché l’European Securities and Markets Authority (ESMA) assuma un ruolo diretto di supervisione sulle principali piattaforme CASP (crypto-asset service providers), specialmente quelle che operano a livello transfrontaliero e che non hanno sede nell’Unione. L’obiettivo è ridurre il rischio di arbitraggio regolatorio e garantire un’applicazione uniforme delle regole, in un settore che per sua natura tende a muoversi oltre i confini nazionali.
Il ragionamento alla base è intuitivo: le grandi piattaforme che gestiscono volumi globali non possono essere controllate efficacemente da singole autorità nazionali. In assenza di un supervisore unico, l’intero impianto MiCA rischierebbe di trasformarsi in un mosaico incoerente, con differenze di enforcement tali da indebolire la credibilità del quadro europeo. Il punto cruciale non è la norma in sé, ma il livello di uniformità nella sua applicazione. Attribuire poteri diretti a ESMA significherebbe rendere effettivo il principio del single rulebook, evitando che la competizione fra autorità nazionali crei disparità sostanziali di trattamento.
Non tutti, però, condividono questa visione. Malta, tradizionalmente hub attrattivo per operatori crypto, ha espresso una contrarietà netta al rafforzamento di ESMA. Secondo la MFSA, la centralizzazione della vigilanza ridurrebbe la capacità degli Stati membri di adattare il regime alle specificità locali e, soprattutto, priverebbe paesi come Malta della leva competitiva che hanno costruito grazie a regolazioni nazionali più flessibili. In sostanza, la posizione maltese difende un modello di pluralismo normativo che ha favorito l’insediamento di imprese ma che oggi si scontra con l’esigenza di armonizzazione europea.
Il conflitto non è solo tecnico, ma politico. Da una parte ci sono i paesi che temono che l’Unione perda credibilità internazionale se non saprà imporre un controllo coerente sulle piattaforme globali; dall’altra ci sono gli Stati che hanno fatto della regolazione leggera uno strumento di attrazione economica e che vedono nella centralizzazione un rischio di desertificazione del settore. La tensione tra armonizzazione e sovranità nazionale si ripropone così nel terreno delle crypto, ricalcando dinamiche già viste in ambito bancario e nei mercati finanziari tradizionali.
Un precedente illuminante è la creazione del Single Supervisory Mechanism (SSM) dopo la crisi del debito sovrano. Allora, di fronte all’urgenza di stabilizzare il sistema bancario, gli Stati membri accettarono di trasferire poteri significativi alla BCE, trasformandola in supervisore diretto delle banche significant institutions. La logica era la stessa che oggi anima Francia, Italia e Austria: garantire che istituzioni di rilevanza transnazionale non sfuggissero a un controllo unitario. Nonostante le resistenze iniziali, il SSM ha consolidato l’architettura bancaria europea, riducendo la frammentazione e aumentando la fiducia dei mercati.
La stessa dinamica si ritrova nel campo assicurativo, dove EIOPA ha visto crescere il proprio ruolo, seppur senza raggiungere un livello di centralizzazione paragonabile a quello bancario. Anche qui, il compromesso tra regole comuni e applicazione nazionale ha mostrato i suoi limiti: la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria restano influenzate dalla qualità della vigilanza locale, con esiti disomogenei nei diversi Stati.
Se caliamo queste esperienze nel caso MiCA, il parallelo è evidente. Le crypto non conoscono confini e operano in tempo reale, con piattaforme che servono utenti in decine di paesi simultaneamente. Pretendere che un’autorità nazionale con risorse limitate possa esercitare un controllo effettivo su operatori globali appare illusorio. Il rischio è che MiCA diventi un regolamento uniforme solo sulla carta, ma frammentato nella prassi.
La posizione maltese, d’altra parte, non è priva di logica. Per un paese che ha costruito parte della sua attrattività economica offrendo un regime favorevole alle imprese crypto, la centralizzazione rappresenta una minaccia diretta. L’argomento secondo cui la conoscenza del tessuto locale consente una vigilanza più mirata ha un fondamento, soprattutto se si considera che l’innovazione tecnologica non procede ovunque alla stessa velocità. Il timore di Malta è che un approccio uniforme finisca per penalizzare i paesi più dinamici, livellando verso il basso la capacità di competere.
Ma la questione non si esaurisce nel conflitto tra Stati grandi e piccoli. È in gioco la stessa idea di mercato unico europeo: se MiCA vuole affermarsi come il quadro di riferimento globale per gli asset digitali, la sua forza dipenderà dalla coerenza dell’applicazione. Un regolamento che produce esiti divergenti rischia di indebolire la credibilitàdell’Europa agli occhi degli investitori internazionali. Al contrario, un sistema centralizzato potrebbe garantire maggiore stabilità, ma al prezzo di ridurre gli spazi di flessibilità normativa.
Il compromesso che si andrà a delineare sarà decisivo. Un rafforzamento parziale dei poteri di ESMA potrebbe emergere come soluzione di equilibrio: lasciando alle autorità nazionali il controllo sulle realtà più piccole, ma attribuendo all’agenzia europea la supervisione diretta sulle piattaforme di rilevanza sistemica. Sarebbe un modello simile a quello bancario, dove la BCE vigila direttamente sulle banche significant institutions, mentre le NCA gestiscono le less significant institutions (LSI).
Le implicazioni per il settore sono profonde. Se prevalesse la linea centralizzatrice, gli operatori dovrebbero confrontarsi con una regolazione più uniforme, riducendo i margini di arbitraggio ma anche aumentando i costi di compliance. Se vincesse la linea maltese, l’Europa continuerebbe a presentarsi come un mercato frammentato, in cui la scelta della giurisdizione diventa un elemento strategico per le imprese, con il rischio di indebolire la protezione degli utenti.
In definitiva, il confronto di questi giorni non è un episodio marginale ma l’anticipazione di un passaggio strutturale. La regolazione delle crypto in Europa si trova al bivio tra due modelli opposti: da un lato l’armonizzazione forte, che punta a consolidare la credibilità del continente come polo regolatorio globale; dall’altro la concorrenza normativa, che difende le prerogative degli Stati ma rischia di generare opacità e disomogeneità.
In gioco non c’è solo la disciplina degli asset digitali, ma la capacità dell’Unione di presentarsi come un mercato unico dei capitali anche nell’era delle tecnologie decentralizzate. La vicenda di MiCA mostra che la sfida non è più scrivere le regole, ma decidere chi avrà il potere di farle rispettare.